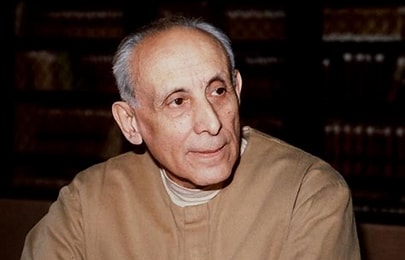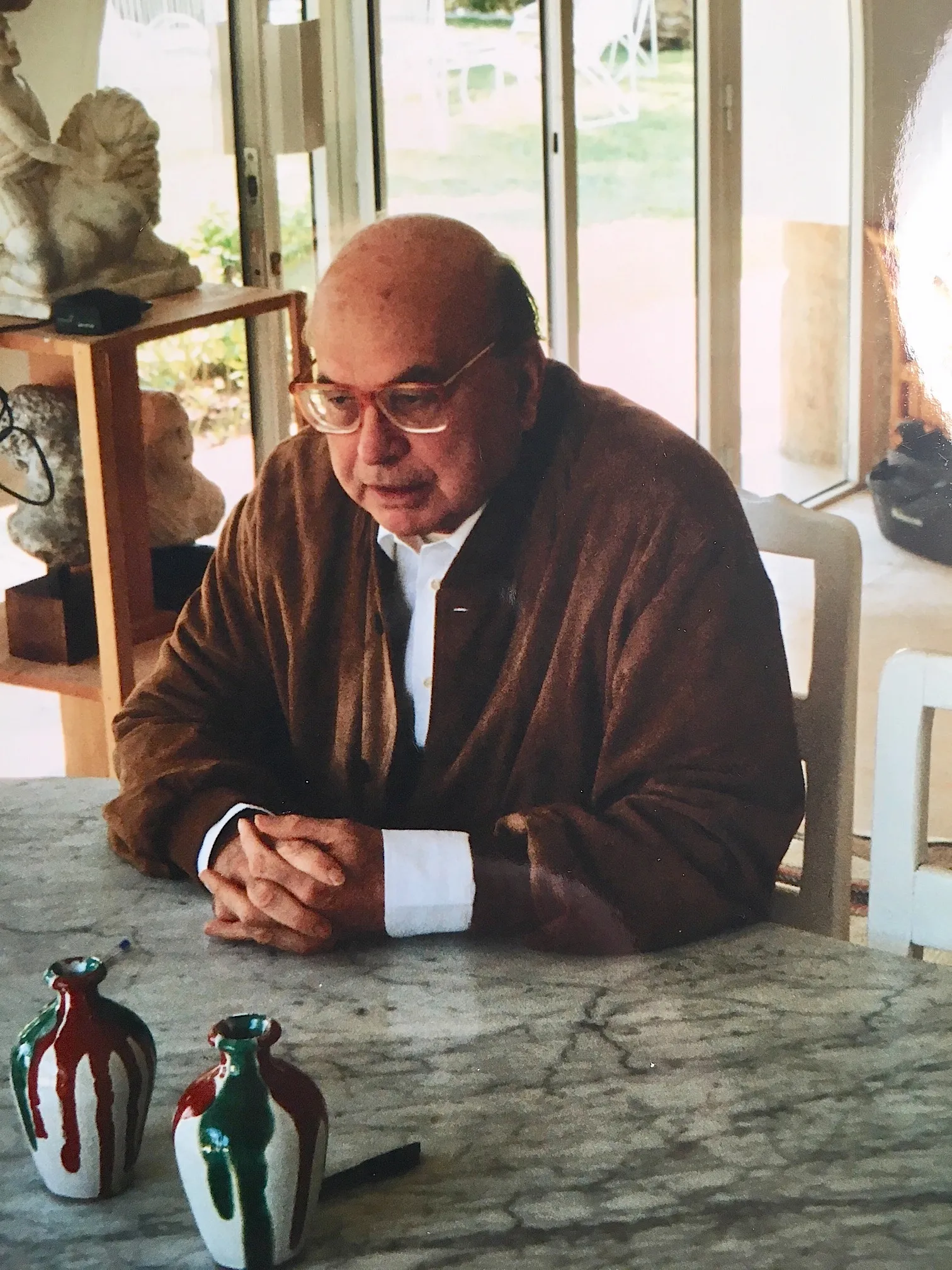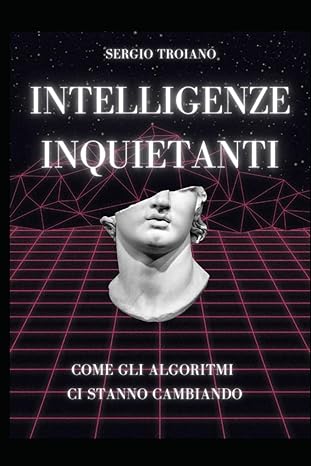Raccontava la sorella di Riccardo Misasi che invitare a casa Ciriaco De Mita era sempre un problema. De Mita e Misasi si erano conosciuti a Milano, all’Università Cattolica, ed erano diventati subito amici. Così, se a casa Misasi si dava una festa, va da sé che De Mita era fra gli invitati. Il fatto è che queste feste servivano anche, in quell’Italia ormai lontana, a far conoscere fra loro ragazzi e ragazze, e poi magari chissà. Ma quando arrivava De Mita, racconta la sorella di Misasi, e cominciava a parlare – di politica è ovvio – i ragazzi invece di fare la corte alle ragazze si mettevano ad ascoltarlo.
Questa capacità di fascinazione era una caratteristica tutta sua. All’università, si riunivano a discutere nella stanza da studenti di uno di loro lui, Gerardo Bianco, Biagio Agnes, Giovanni Di Capua, Misasi, gli amici di una vita, fra alterne vicende, insieme con Nicola Mancino, Antonio Aurigemma, altri ancora … Anche in collegio, quando De Mita parlava gli altri restavano affascinati ad ascoltare. Giovanni Di Capua raccontava così quegli incontri: “adesso apriamo la finestra e De Mita vola”.
I ragionamenti di De Mita erano una forma di pedagogia politica. Non era semplice seguirli, per questo li accompagnava con certe immagini, del medico, del nonno, tratte da un mondo fantastico popolare che aiutava a comprendere. Citava don Lorenzo Milani: “quando si sceglie insieme si fa politica, quando si sceglie da soli si è egoisti”. E’ il principio del processo democratico tante volte richiamato da Aldo Moro, altro suo costante riferimento: la democrazia intesa come “il tempo della decisione”, il tempo necessario a spiegare, convincere, e dunque a scegliere insieme, recuperando il senso classico della saggezza romana: “quod omnes tangit, ab omnibus approbari debet”. Sta qui il senso di quegli interminabili incontri tenuti con la base del partito in tutta Italia, alla ricerca di una consapevolezza comune.
Citava don Luigi Sturzo, De Mita: durante tutto il tempo della segreteria politica dal maggio 1982 al febbraio 1989 e sempre nella sua vita, è stato grande sostenitore del popolarismo sturziano, con il suo carico di ispirazione cristiana da tradurre nella sfera politica. L’ispirazione cristiana come mediazione fra cielo e terra, fra amore divino e giustizia umana, tra fede e ragione, solidarietà e interesse, fra il senso ultimo del destino dell’uomo e i conflitti legati all’esistenza quotidiana. La sfida di raggiungere l’impossibile della politica attraverso quell’altro impossibile proprio di un politico cattolico: la fede in Dio. Se perdiamo questo collegamento con l’identità cattolica, diceva, la Democrazia cristiana diventa inutile.
Spiegava così De Mita il suo cercare di immedesimarsi nella realtà del Paese: “Non basta capire da soli. Il problema è che la nostra comprensione diventi il fatto, il sentimento della gente. Noi vinciamo, spieghiamo, dimostriamo che la nostra intuizione è giusta, che la nostra missione funziona, quando la nostra idea, la nostra motivazione si traduce nel sentimento delle persone. Sturzo aveva pensato tutto questo con straordinaria lungimiranza prima ancora di fare il Partito popolare”.
Uno dei riferimenti culturali iniziali di De Mita – con Antonio Rosmini, Guido Dorso, Piero Gobetti, Antonio Gramsci – era stato Guido De Ruggero con la sua Storia del liberalismo europeo. Lo affascinava il grande affresco tracciato da De Ruggero sui modi nei quali il liberalismo si fosse sviluppato nei Paesi europei, con quali differenze legate ai diversi vissuti storici dei Paesi nei rapporti fra aristocrazia, borghesia e monarchia. Quella lettura era il suo grande salto culturale dal contesto sapienziale, ma anche ingenuo della piccola realtà montanara dalla quale proveniva, la Nusco a mille metri d’altezza in provincia di Avellino dove era nato il 2 febbraio 1928, alla comprensione del più vasto mondo intorno a lui.
Era quanto gli aveva preparato il destino, lui figlio di don Peppino, modesto sarto e portalettere di Nusco. Il suo ascensore sociale fu azionato dal parroco del paese. "Don Peppino - disse questo sacerdote al padre - tuo figlio è troppo intelligente, deve continuare a studiare, lo aiuterò io”. Fu così che De Mita prese da privatista la licenza liceale, ed ebbe poi la borsa di studio per frequentare l’Università Cattolica a Milano.
I suoi professori l0 avrebbero voluto assistente universitario, ma lui una volta laureato in giurisprudenza tornò nella sua terra, il suo orizzonte era la politica. Oltre De Ruggero, un altro riferimento culturale intorno a cui ruotò questa predisposizione fu L’ordinamento giuridico di Santi Romano. Mutuò da Santi Romano l’idea, che è stata poi un’altra costante della sua visione politica, dei partiti come “istituzioni della democrazia”, nella pienezza della scarna, ma altrettanto incisiva indicazione dell’articolo 49 della Costituzione: “Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”.
Questi riferimenti culturali trovarono il loro compimento nel popolarismo di Sturzo, che diventa il suo popolarismo. De Mita lo ricordava nell’ultima conversazione politica avuta con lui nel febbraio del 2022, tre mesi prima della morte il 26 maggio, pubblicata a cura di Andrea Manzella e del sottoscritto nel fascicolo di luglio-settembre 2023 di Nuova Antologia: “Io penso di avere svolto una funzione da frate predicatore, perché è un peccato non ricordarlo: non c’è altro pensiero politico più vivo del popolarismo, ma come momento della politica, non la sua fine. Può arricchirsi o modificarsi: e se si modifica vuol dire che il pensiero va avanti. Diversamente, presto o tardi noi annulliamo tutto e non si sa che cosa possa succedere. Perciò ripeto da tempo che la vera novità che può essere introdotta nella politica italiana è rifare il pensiero dei popolari come Sturzo ha insegnato. Lo spirito politico è fatto così, di umiltà e di grande ambizione …”.
Sturzo rivendicava la paternità della espressione popolarismo, che descriveva così: “Il popolarismo si contrappone al fascismo e al comunismo, così come al liberalismo e al socialismo … il dato moderno è quello di uno Stato rappresentativo, come fonte di diritti e delle libertà politiche e dell’uguaglianza delle leggi. Il popolarismo accetta questi presupposti di fatto ma dà loro una sua interpretazione e un suo proprio significato. Il popolarismo nega lo Stato come fonte di diritti, in quanto la fonte del diritto è la personalità umana nella sua relatività sociale; lo Stato non è che una forma di società umana, la forma di una società politica limitata nel tempo e nello spazio … lo Stato non sopprime, non annulla non crea i diritti naturali dell’uomo, delle famiglie, delle classi dei comuni, della religione; semplicemente li riconosce, li tutela, li coordina nei limiti della propria funzione politica. Lo Stato non è al di sopra della libertà, la riconosce e ne coordina e limita l’uso perché non degeneri in licenza …”.
Sono riflessioni altissime sul rapporto fra il cittadino e lo Stato; sono la traduzione politica della celebre espressione di Pio XI: “Il fine dell’uomo non è lo Stato, ma l’uomo è il fine dello Stato”. È la cultura cattolica che ha portato all’articolo 2 della Costituzione: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità …”. La Repubblica riconosce i diritti preesistenti dell’uomo, non è essa a concederli. Si compie così il passaggio dallo Stato accentratore, paternalista e autoritario dell’Ottocento a quello dei nostri giorni.
Queste coordinate culturali e costituzionali sono la chiave di lettura del progetto politico che aveva in mente De Mita. Senza di esse non si comprende il senso dei suoi “ragionamenti”, come qualcuno con intento irrisorio, anche dentro il partito, a volte li etichettava. Anche Zaccagnini veniva chiamato “l’onesto Zac” riducendo a questo la sua testimonianza impegnata nella “politica del confronto”, che risultò poi vincente nella sfida degli anni Settanta con il Partito comunista. L’onestà: si è visto negli anni successivi quanto questa fosse decisiva per la legittimazione stessa della politica.
Per De Mita la moralità della politica era la sua efficienza. “Ciò che non funziona – dirà nel discorso di replica alla Camera all’insediamento del suo governo il 21 aprile 1988 – è l’organizzazione delle prestazioni, ed è inutile parlare di risanamento della spesa pubblica, di moralità nella gestione della cosa pubblica, se noi non interveniamo su questi meccanismi che non funzionano portandoli all’efficienza”. Fenice, l’antico istitutore di Achille, così riassumeva l’arte del buon governante: “Sa dire parole e portare a termine fatti”. Quando Gianni Agnelli gli dette dell’ “intellettuale della Magna Grecia”, nell’astrattezza di un tale riferimento finiva con il riconoscere a De Mita proprio questa concretezza.
Il cursus honorum di De Mita nella Democrazia cristiana è quello tradizionale e duro di una volta rispetto alle improvvisazioni odierne. De Mita entra nel partito all’inizio degli anni Cinquanta, la provincia di Avellino era dominata allora dalla figura di Fiorentino Sullo, politico intelligente e sfortunato. De Mita è segretario provinciale, tenta una prima volta l’elezione parlamentare, non riesce, diventa deputato nel 1963 e resta alla Camera fino alla fine della DC. Nel partito è tra i fondatori della corrente della “Base”, con un asse Sud – Nord che a Milano ha la sua espressione in Albertino Marcora, a Bergamo in Luigi Granelli, a Venezia in Wladimiro Dorigo, a Firenze in Luigi Pistelli, in tanti altri che si potrebbero citare, uomini e donne, come Tina Anselmi.
La scalata dentro il partito ha una svolta con il convegno di “San Ginesio”, nelle Marche, del settembre 1969 e l’accordo stipulato in quella occasione con Arnaldo Forlani. Dopo la prima generazione dei De Gasperi, dei Guido Gonella, dei Mario Scelba, e la seconda generazione degli Aldo Moro, degli Amintore Fanfani, dei Giulio Andreotti, i “cavalli di razza” della DC, adesso è la volta della terza generazione, i quarantenni protagonisti di San Ginesio. Due mesi dopo Forlani diventa segretario del partito, De Mita diventa vice segretario.
San Ginesio non è solo un passaggio generazionale. I tempi sono cambiati, c’è stata una prima edizione del “centro sinistra”, c’è il turbamento sociale prodotto dalla contestazione giovanile del 1968, in Italia sta per arrivare la legge sul divorzio, stanno per nascere le Regioni, il rapporto con la “questione comunista” si pone in termini nuovi rispetto alla contrapposizione radicale del 1948. De Mita dà la sua interpretazione del convegno di San Ginesio nella Intervista sulla DC ad Arrigo Levi pubblicata da Laterza nel 1986: “San Ginesio fu l’occasione per una riflessione che muoveva dalla constatazione che lo spazio di governo fondato sul centro-sinistra era ridotto, che la prossimità tra Dc e Pci era aumentata, e che il Pci stesso aveva superato le difficoltà del 56, che esso era uscito cioè dal suo isolamento politico. Da qui l’esigenza di elaborare una strategia di rapporto con il Pci che lo rendesse protagonista più attivo nella vicenda politica italiana. Il Pci aveva avuto una notevole crescita culturale e politica e aveva acquisito consensi; era difficile vederlo tutto contenuto dentro lo spazio tradizionale dell’opposizione”.
Dopo San Ginesio si è discusso a lungo della collaborazione, e poi della rivalità tra Forlani e De Mita. Il loro conclusivo alternarsi alla segreteria del partito al XVIII congresso nazionale della DC del febbraio 1989, è stato l’ultimo della storia democristiana. Molti anni dopo, mercoledì 16 novembre 2011, De Mita e Forlani si sono trovati insieme, protagonisti di una manifestazione per i 150 anni dell’Unità d’Italia, organizzata a Roma da Pierluigi Castagnetti a nome dell’Associazione nazionale dei popolari. Per l’occasione uscì un’edizione straordinaria del “Popolo” sul contributo della Democrazia cristiana alla vita democratica del Paese. Nel suo intervento, Forlani fece una battuta che è come un riepilogo dei loro rapporti: “De Mita e io eravamo d’accordo anche quando non andavamo d’accordo. Perché questa è stata la DC. Poi la Democrazia cristiana si è lasciata sciogliere. Un giorno ne dovremo parlare, e se avremo questa possibilità proveremo a spiegare un po’ meglio che cosa è avvenuto e che cosa non è avvenuto”.
Una nota biografica non può esaurire la complessità di un personaggio come De Mita, può richiamare semmai le diverse linee dalle quali ricavare il quadro d’insieme. C’è la parte governativa, anche questa una lunga progressione iniziata nel lontano 1968 – 69 come sottosegretario all’Interno. Nel 1973 – 74 è poi ministro dell’Industria, nel 1974 – 76 ministro del Commercio con l’estero, nel 1976 – 79 ministro del Mezzogiorno. Dal 13 aprile 1988 al 22 luglio 1989 è stato infine Presidente del Consiglio, in coincidenza con gli avvenimenti storici che porteranno alla caduta del muro di Berlino nel novembre del 1989 e al crollo dell’URSS. De Mita è un protagonista del dibattito internazionale sulla fine del comunismo, e avanza la proposta di un piano Marshall per i Paesi dell’Est europeo che li spinga a trovare percorsi di un nuovo sviluppo insieme economico e democratico.
Se sul piano internazionale, oltre agli impegni in vista della costruzione del mercato comune europeo che porterà al trattato di Maastricht del 1992, il grande riferimento del governo De Mita è l’attenzione all’Est, sul piano interno la scommessa riguarda la riforma delle istituzioni. Nel discorso programmatico alla Camera del 19 aprile c’è verso la fine una frase chiave rivolta al Pci, dopo avere illustrato i progetti di riforma: “… il governo spera di non essere solo nel far fronte a questi compiti. Spera di avere, con la fiducia, anche il sostegno costante di questo Parlamento. Spera di ottenere dalla opposizione un contributo di critica e magari qualcosa in più sui grandi temi unificanti”.
“Qualcosa in più”, ma non sarà così. Tre giorni prima di questo discorso, il 16 aprile, un fatto atroce è il presagio funesto del fallimento al quale sono destinati i sogni di De Mita. A Forlì le brigate rosse uccidono barbaramente Roberto Ruffilli, il suo principale collaboratore sul tema delle riforme, dai tempi della prima commissione parlamentare per le riforme presieduta dal liberale Aldo Bozzi fra il 1983 e il 1985. Anche quella era stata una delusione, pur essendosi conclusa con un serioso progetto di modifiche costituzionali, rimaste sulla carta. De Mita si era battuto perché fosse Fanfani a presiederla, e gli altri partiti gli dissero di no. Entrò a farne parte insieme a Ruffilli e chiese a Enrico Berlinguer e Bettino Craxi di partecipare anche loro, ma rifiutarono.
La storia politica di De Mita somiglia per questi aspetti a quella di Cassandra. Vedeva chiaramente il futuro nel sollecitare il sistema dei partiti, allora ancora forti e rappresentativi, a dare vita a una nuova stagione costituente, ma non fu ascoltato. Poneva il problema del superamento dello schema destra sinistra nel nome di quello tra il vecchio e il nuovo, ma anche qui ebbero la meglio le resistenze. Sosteneva una legge elettorale che favorisse le coalizioni nel nome del “cittadino arbitro”, la suggestiva espressione di Ruffilli, e invece abbiamo avuto leggi elettorali che costringono ad alleanze forzate partiti incompatibili fra loro. Finalmente De Mita fu eletto nel 1992 a presiedere una nuova commissione parlamentare per le riforme, ma nella bufera delle vicende legate a tangentopoli bastò un avviso di garanzia contro un suo fratello a costringerlo alle dimissioni. Oggi siamo di nuovo di fronte allo scontro degli anni Ottanta con Craxi, tra forma di governo parlamentare o presidenziale.
Anche nel partito, il suo disegno di superare la logica delle correnti si scontrò con un sistema di potere che aveva scalzato nel tempo il senso di correnti nate sulla base di visioni ideali della società italiana e del suo divenire. Era il 1984, direzione DC del 18 aprile. De Mita propose dei supervisori per riorganizzare il partito nelle grandi città: Guido Bodrato a Torino, Roberto Mazzotta a Milano, Pierluigi Castagnetti a Bologna, Giuseppe Matulli a Firenze, Nicola Signorello a Roma, poi sarà Francesco D’Onofrio, Ugo Grippo a Napoli, Silvio Coco a Palermo, poi sarà Sergio Mattarella, poi ancora sarà la volta di Filippo Peschiera a Genova. E’ l’atto di nascita di quelli che saranno (alcuni tra di loro) i “colonnelli” di De Mita. L’anno successivo De Mita avrebbe voluto far eleggere direttamente dalle sezioni i delegati al congresso nazionale, scavalcando il controllo delle correnti sui delegati.
Ma l’epilogo di tutto questo fu, a dicembre del 1988, l‘accordo fra Andreotti, Forlani e Antonio Gava che scalzerà De Mita dalla guida del partito e del governo al XVIII congresso del febbraio 1989. La data esatta della fine politica di De Mita è segnata nei miei appunti, è martedì 27 dicembre 1988. Lo ricordo quel giorno, perché fui io a dover dire a De Mita che l’avventura così straordinaria della sua vita politica ai massimi livelli si concludeva lì. Era in corso un consiglio dei ministri quando l’Ansa, poco prima delle 15, batté una dichiarazione di poche parole di Andreotti, sul fatto che lui, Forlani e Gava avevano trovato un accordo sul futuro congresso del partito. Nella DC cambiava dunque la maggioranza interna, De Mita e la sinistra finivano in minoranza con gli esiti successivi che sappiamo. Alla fine del consiglio, i ministri erano nella stanza di De Mita per farsi gli auguri di buon anno. Quando si avvicinò Gava, De Mita invece di stringergli la mano gli dette da leggere le tre righe dell’Ansa che gli avevo portato. Gava lesse e fece un sorriso imbarazzato. Restituendo il bigliett0 gli disse in dialetto: “nun te preoccupà, Cirì”.
Per De Mita la politica era tutto, lo sappiamo. E soprattutto, diceva, la politica è l’esercizio di una funzione, guai se diventa la gestione di un potere, perché questo rovina la nobiltà della politica alla quale tendere. La storia della migliore Democrazia cristiana è stata questa. Le trattative per la formazione del governo De Mita durarono dal 16 marzo al 13 aprile 1988, 28 giorni di fuoco, che ho potuto seguire giorno per giorn0, e direi ora per ora, partecipando a tutti gli incontri con tutte le diverse delegazioni politiche e sociali, prendendo gli appunti necessari per verbalizzare lo stato delle posizioni e degli accordi. Quando c’erano i socialisti, Craxi era seduto accanto a me. Mostrava insofferenza, aveva un modo singolare di fumare le sue sigarette lunghe e sottili. Accendeva, dava qualche tirata, spegneva la sigaretta e la metteva nella tasca della giacca. Dopo un po’ la riprendeva e ripeteva la stessa operazione.
Questo mese di trattative l’ho raccontato in Piazza del Gesù, un diario politico, edito da Mondadori nel 2005. Non è un vanto, è una constatazione dire che si tratta credo dell’unica testimonianza esistente nella letteratura politica sulla “prima repubblica” su come avvenisse il confronto tra i partiti in un momento cruciale come quello della formazione di un governo. Il linguaggio, le parole, i gesti, i comportamenti anche personali sono un quadro dell’antropologia politica dell’epoca. Giorgio Almirante aveva un fair play consumato: “Fuori di qui, caro De Mita, non potrò dirlo, ma ti faccio tanti auguri. Vedi, ho portato con me Gianfranco Fini, lui è il futuro del mio partito”. Durante uno degli incontri con la delegazione liberale Giovanni Malagodi, capo storico dei quel partito, mostrò una gran fretta, che poi spiegò: “Scusate – disse – ma oggi vado a sposarmi”. Aveva credo più di ottanta anni.
Nel 2015 la Camera dei deputati ha pubblicato un lavoro intitolato Il linguaggio della leadership politica tra la prima e la seconda repubblica. Era il risultato di una ricerca compiuta a cura dell’Università La Sapienza grazie a un finanziamento del MIUR del 2010, curatore il professor Luca Giuliano, con il patrocinio dell’Istituto Sturzo, preziosa frontiera della cultura politica cattolica. Un gruppo ben assortito di docenti con competenze trasversali aveva preso in esame i discorsi parlamentari di una serie di esponenti politici, fra i quali De Mita, mostrando i cambiamenti nel tempo. Andrebbe ripreso uno studio del genere, per una ulteriore comparazione con l’oggi.
Su De Mita sarà necessaria una riflessione che faccia realmente il punto sulla sua complessa vita politica e l’intreccio con la DC e la realtà italiana specie degli anni Ottanta. Quando nel 1982 diventa segretario politico, il Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, è socialista, il presidente del Consiglio, Giovanni Spadolini, è repubblicano. Perse le elezioni del 1983, a Palazzo Chigi andrà poi Bettino Craxi. Negli anni De Mita recupererà elettoralmente il partito, ribalterà il “sorpasso” del Pci alle elezioni europee del 1985, con Francesco Cossiga farà tornare un democristiano al Quirinale, con Giovanni Goria un democristiano a palazzo Chigi, con Biagio Agnes alla Rai fronteggerà l’ascesa televisiva di Silvio Berlusconi.
In politica estera si batterà anche per le esperienze democristiane in Cile, in Venezuela, in Salvador, in Guatemala. Si occuperà dell’Europa, Per tre legislature sarà parlamentare a Strasburgo. Erano anni che sembravano prefigurare un duraturo rilancio della Democrazia Cristiana, ed era invece il canto del cigno. C’è ancora molto da capire e da riflettere su questa personalità, il cui ricordo è ostinatamente rivolto, in tanti di noi, non al passato, ma al futuro.
Giuseppe Sangiorgi