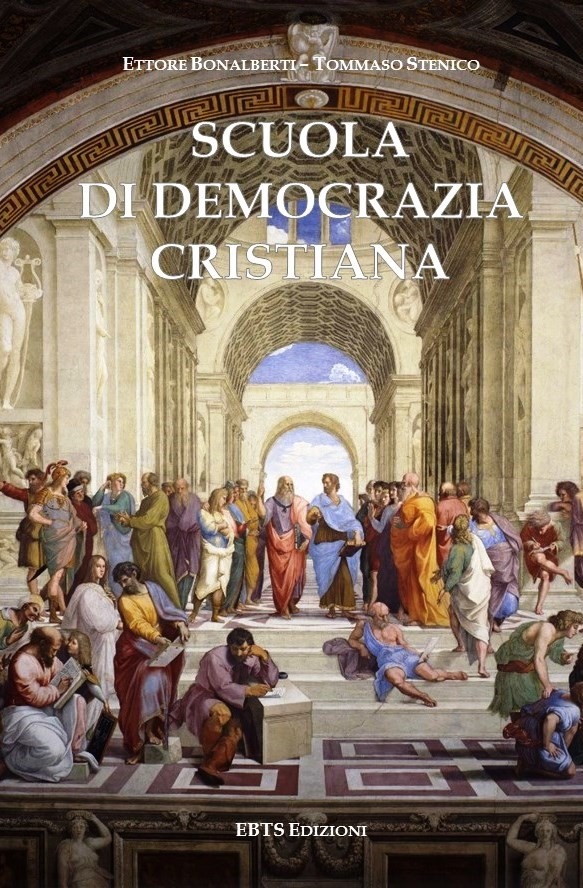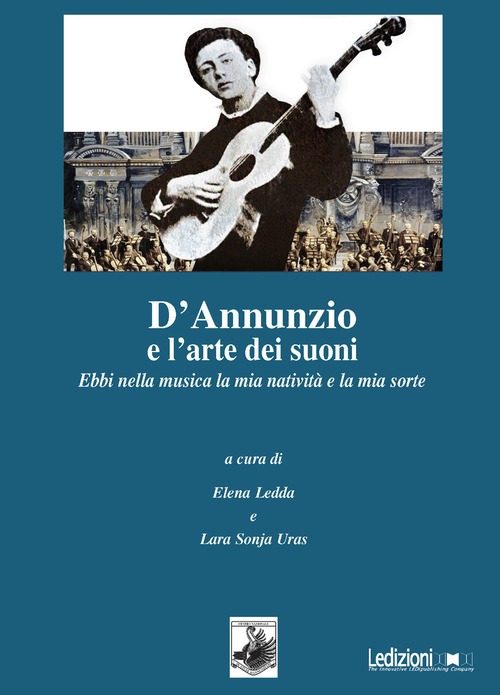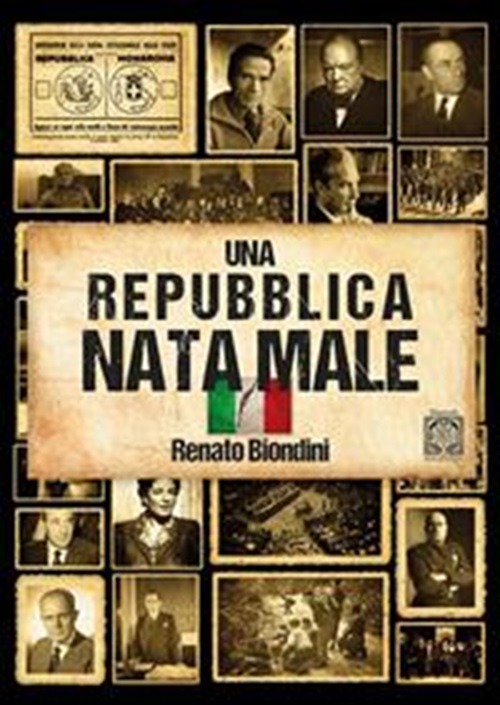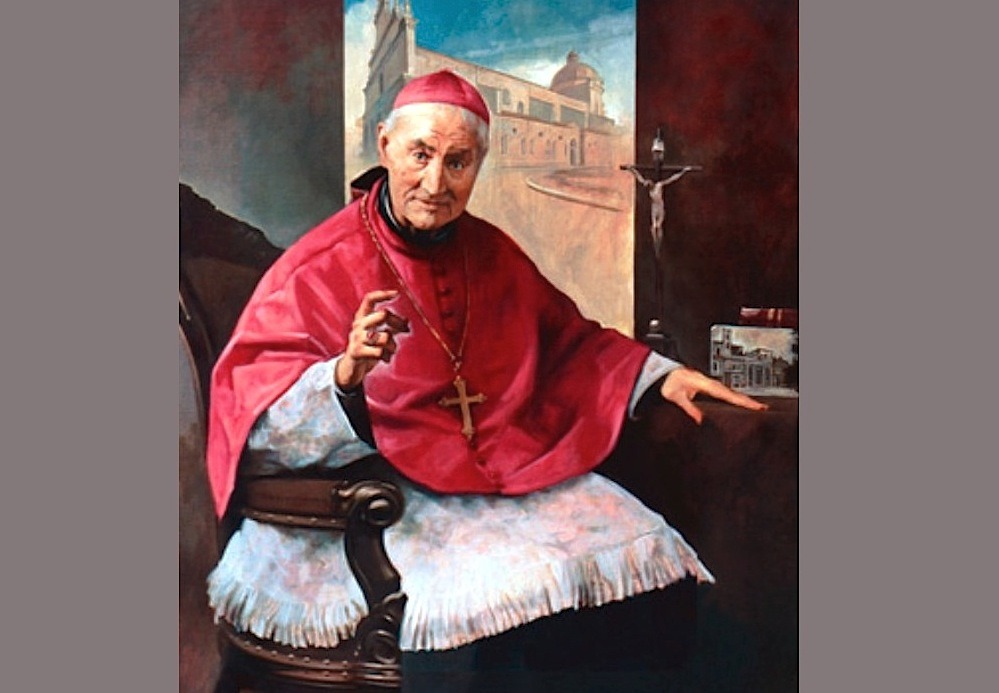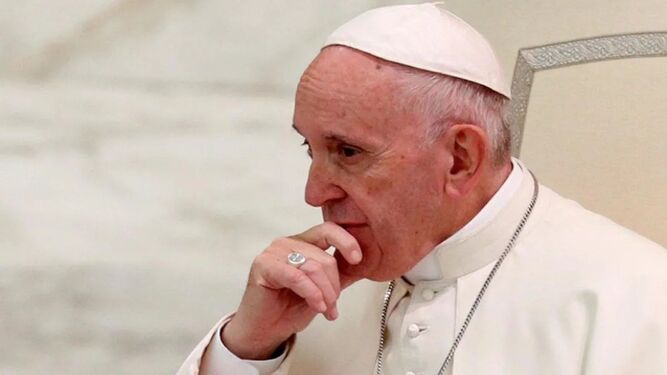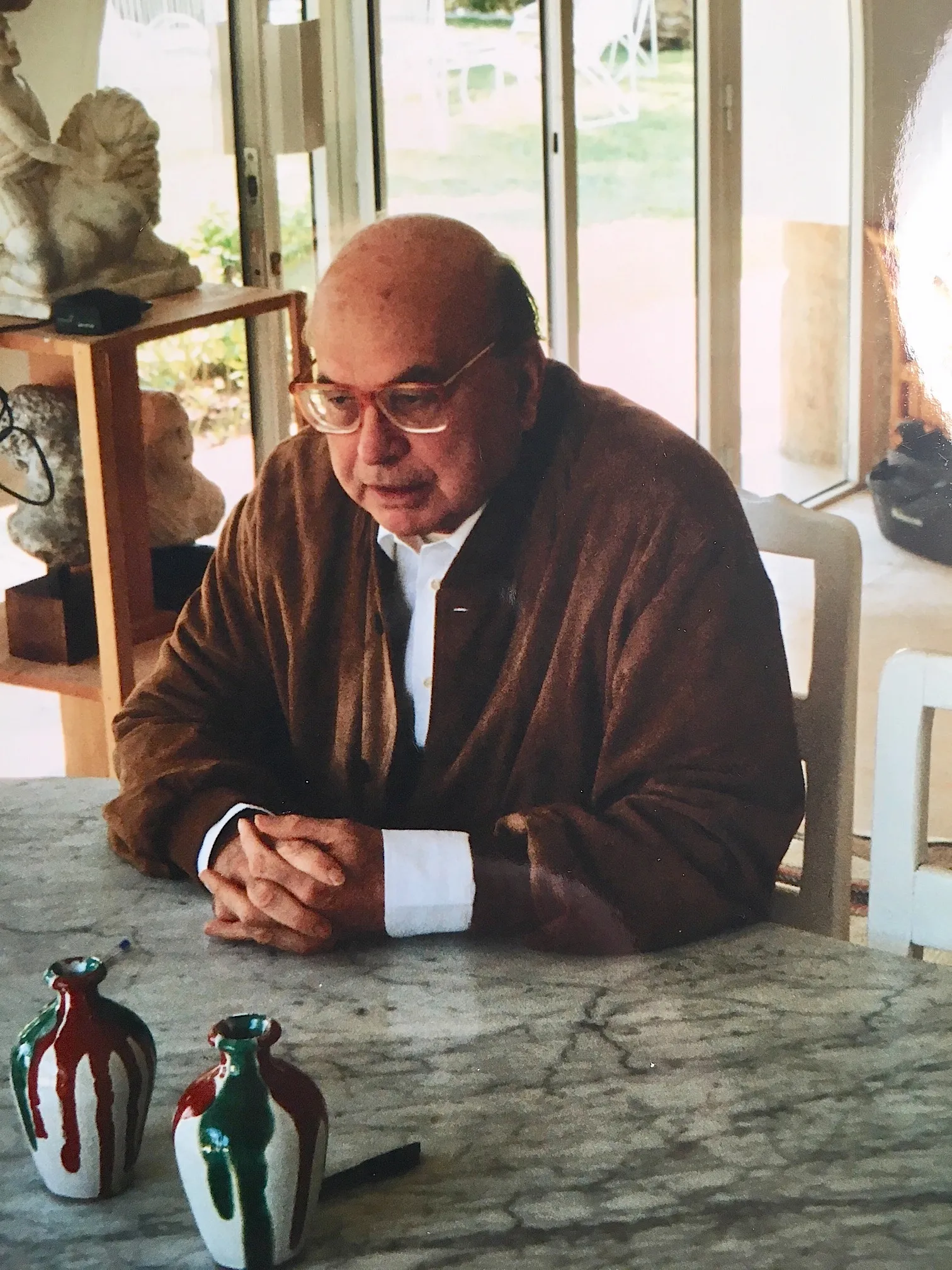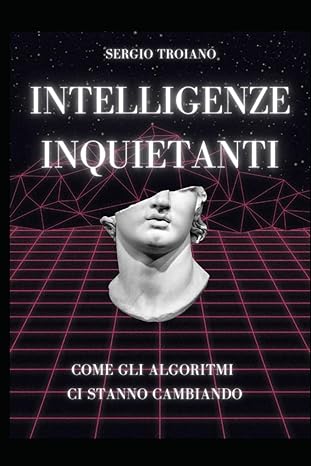di Ruggero Morghen
Dall’archivio del compianto Luigi Menapace l’amico Domenico Gobbi, che già in tempi non sospetti ne curò la vasta bibliografia, ripesca – e pubblica sul suo “Civis” – uno scritto (inedito?) del bibliotecario-giornalista di Rallo su Alcide Degasperi, scritto introdotto da una ben condivisibile avvertenza. Che cioé “se i nostri contemporanei, invece di scrivere trattati acrobatici per dimostrare quello che Degasperi non è e non è mai stato, si mettessero con umiltà e con animo sereno a rileggere tutto quello che Degasperi ha scritto, la figura del grande statista risulterebbe nella sua verità e il lettore sarebbe condotto a intenderla, e non a fraintenderla”.
Per la conoscenza di Degasperi – ritiene Menapace (e noi non si può non concordare) – sono della più grande importanza, dopo i suoi scritti, le sue letture. Il riferimento è a quel che si definisce “discorso sugli studi”, ossia alla storia della sua formazione spirituale, mentale e culturale, “indispensabile – aggiunge il ricercatore noneso – per comprendere l’opera che ne è seguita”: in questo caso un’opera “pensata e tradotta nella prassi politica”.
In particolare le lettere di Degasperi dalla prigione aiutano a comporre il suo “discorso sugli studi”, riportando esse richiami frequentissimi al Vecchio e al Nuovo Testamento (citato più volte nel latino di San Girolamo) nonché ai due maggiori (anzi massimi) nostri, ossia Dante e Manzoni. Ma poi lo statista trentino leggeva, tra gli altri, lo scrittore francese Honoré de Balzac. Ora – osserva Menapace – “nella sua grandiosa ricostruzione della società che gli era contemporanea, Balzac è il rovescio della Divina Commedia, o piuttosto, è la sua prima parte, è l’inferno umano, il mondo senza la fede e la grazia”.
Quanto alla dottrina sociale e politica di Degasperi, essa aveva radice in validissimi scrittori dell’ultimo Ottocento e del primo Novecento. Uomini come il grande Ludwig Windthorst, che “aveva analizzato la teoria e poi trascritto in pratica politica la funzione dei cattolici tedeschi nel forte partito del Centro”, rimasto sulla scena fino all’avvento al potere di Hitler.
Ecco poi i contemporanei, gli amici trentini cui idealmente egli si rivolgeva mentre a Roma era intento nella diuturna opera sua: quella – per dirla con Menapace – di “rappezzare l’Italia”. Il riferimento è in particolare a Giovanni Ciccolini, don Giulio Delugan e mons. Simone Weber, tutti “legati all’azione del laicato cattolico trentino nei settori organizzativo e politico”. In particolare il primo e l’ultimo hanno lasciato una traccia notevolissima nel campo degli studi storici. “Per questo – osserva conclusivamente Menapace – non fa meraviglia che la loro amicizia verso Degasperi avesse anche una colorazione di stima reciproca sul terreno della seria formazione culturale”.