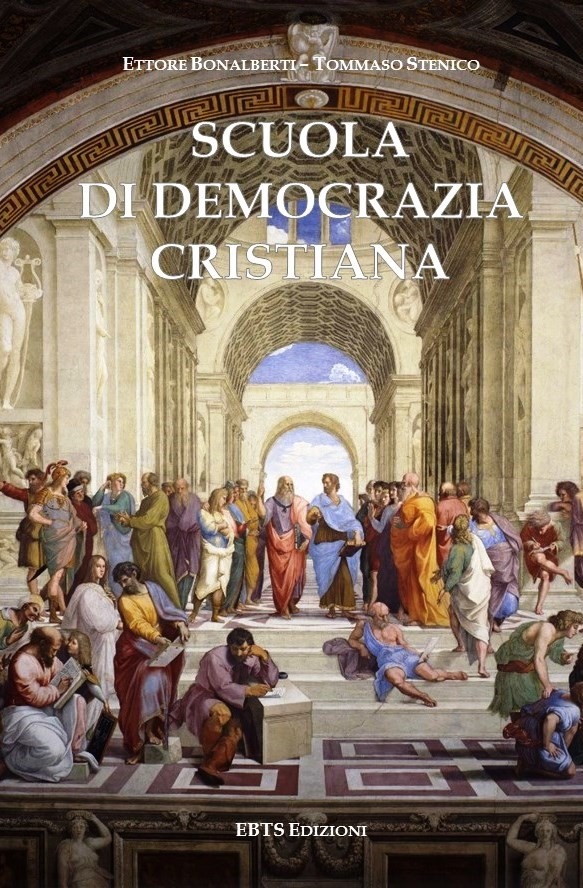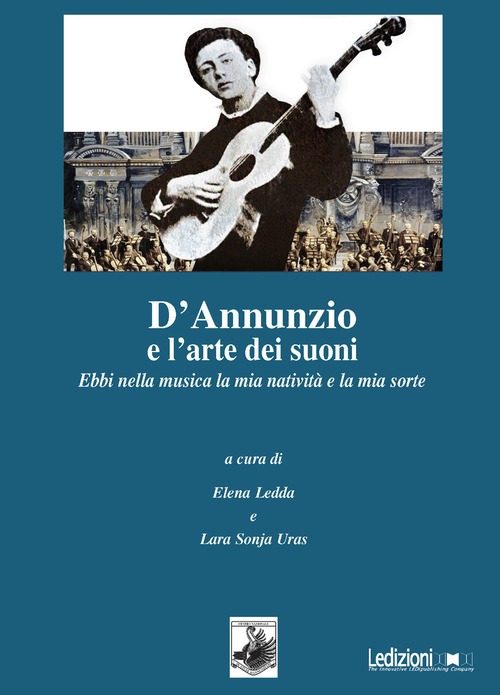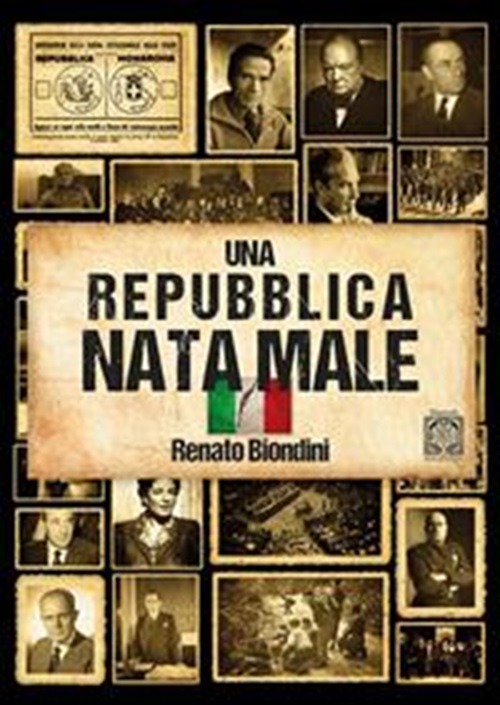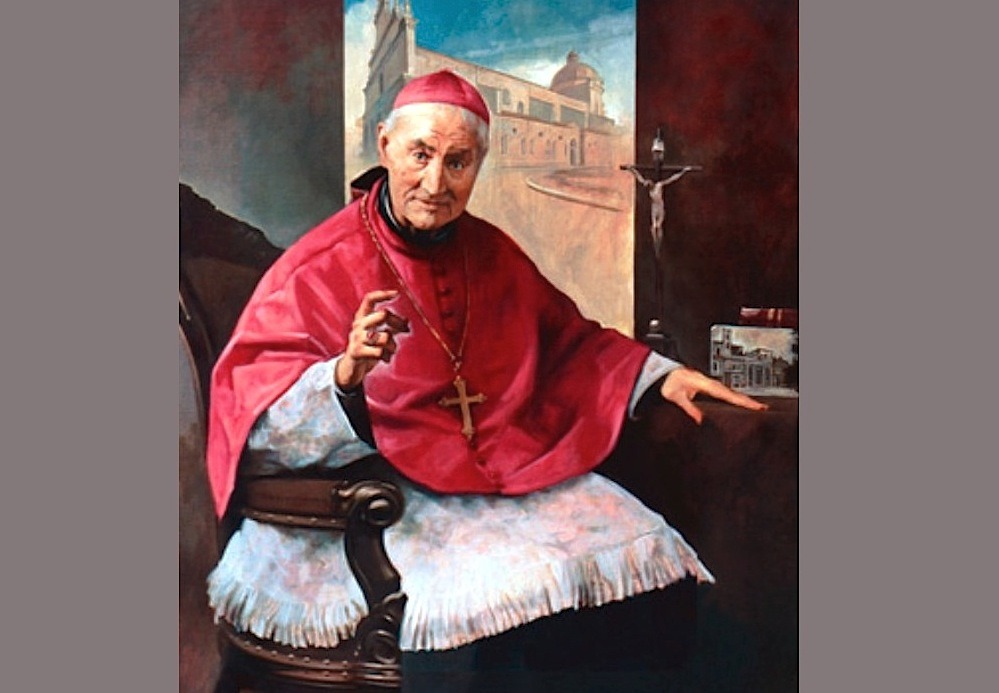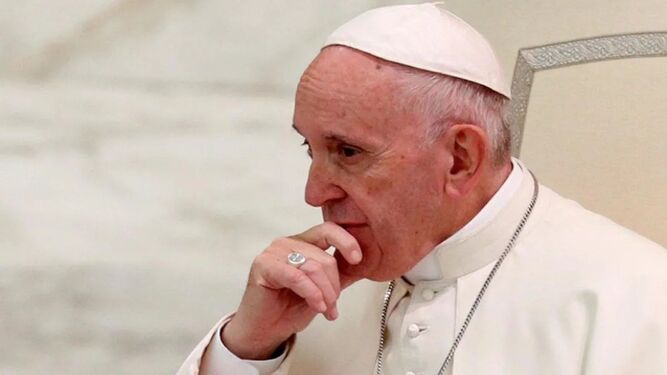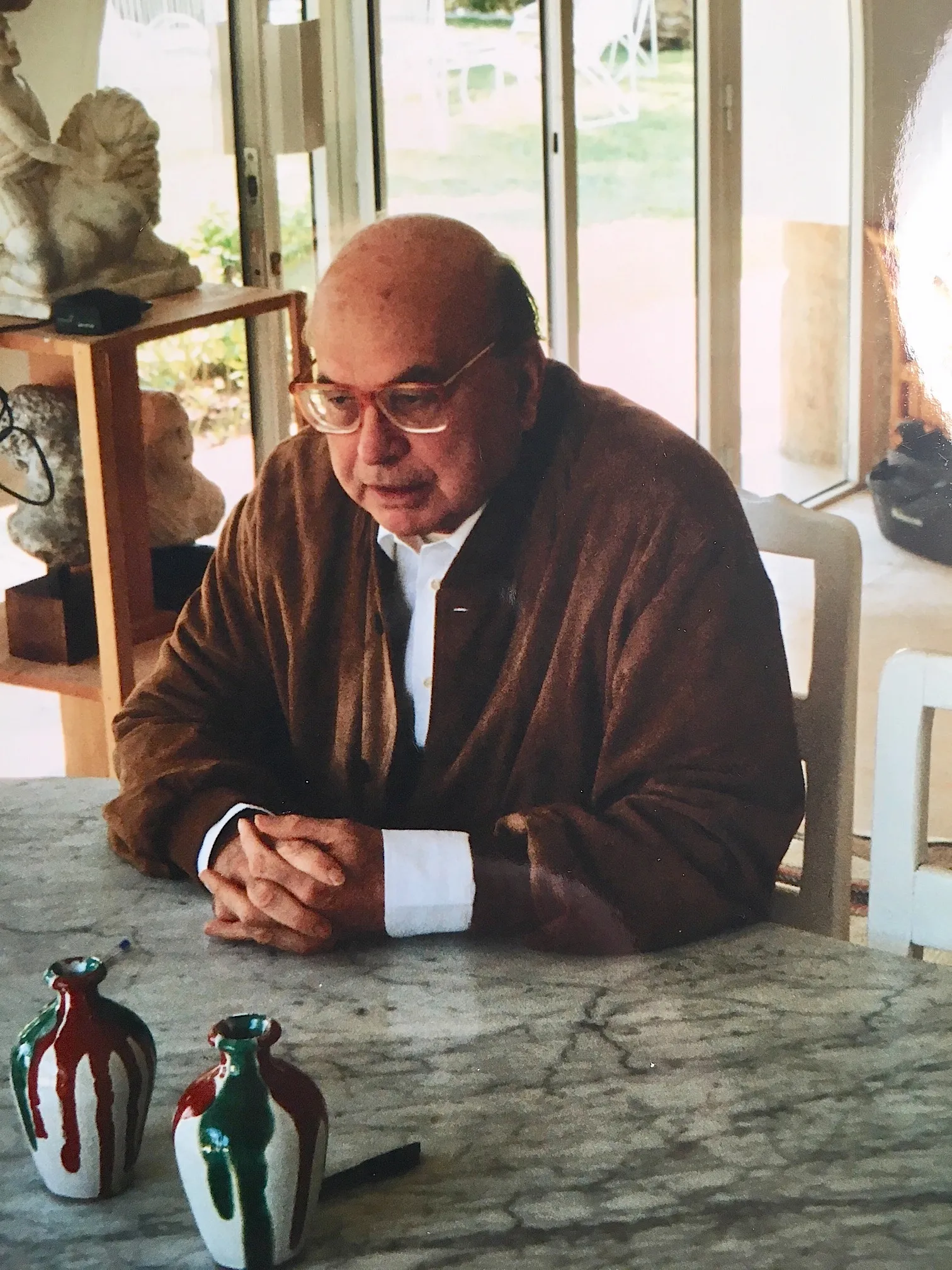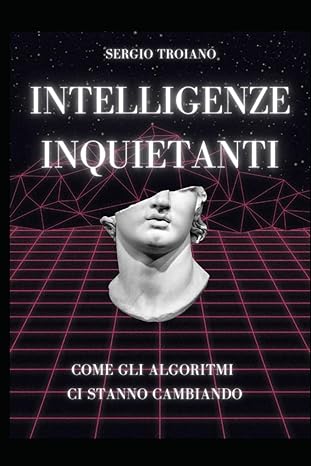di Ruggero Morghen
“Il concetto di focolare, di formar famiglia – spiega il presidente della Repubblica Sergio Mattarella - contiene un richiamo costante, generale al senso di comunità”. Il Focolare, affermava dal canto suo Chiara Lubich a Loppiano il 12 giugno 1980, “dovrà essere un focolare: amore che brucia”; quindi aggiungeva: “Dio vuole in questo luogo soprattutto un incendio di amore e ognuno deve prestarsi come combustibile”.
Affascinata dal nuovo ideale, nell’autunno del 1944 Giosi Guella va ad abitare con Chiara Lubich nel primo Focolare, sito a Trento in piazza Cappuccini 2. Sarà anzi la prima, ricorda Marco Tecilla, a sua volta primo Focolarino maschio. La Lubich lo definirà “la Casetta” in ricordo di un’esperienza da lei fatta a Loreto, presso la Santa Casa, nel 1939 allorché avvertì una voce che le diceva: “Sarai seguita da una schiera di vergini”. Come lo stuolo di vergini che, secondo la testimonianza di suor Benvenuta di Madonna Diambra, visitò santa Chiara morente. In quell’occasione, vissuta dalla fondatrice come un prodromo dell’Opera di Maria, si svolgeva un corso di studentesse cattoliche. “Ad ogni intervallo del corso – ricordava la Lubich – corro sempre lì, alla Casetta. Quella convivenza di vergini con Gesù fra loro ha un’attrattiva irresistibile”.
La Casetta di Trento era una baracca in muratura di due stanzette oltre la cucina, un appartamentino in un vecchio edificio color mattone rossiccio costruito a ridosso di un’antica cava di pietra. “Era una piccola riproduzione proprio della Casetta di Nazareth - nota Lucia Abignente – e ingenuamente venne definita casetta dell’amore”. Giosi Guella, parlando nel marzo del 1967 agli allievi della scuola di Loppiano, afferma: “La casetta era proprio bella perché non c’era niente. Nello stesso tempo c’era tutto: per noi e per gli altri”. “Era logico – osserva quindi – che non ci fosse niente, perché quando c’era qualche cosa la si donava”.
Palmira Frizzera, che alla fine di un corso seguì “quelle cosiddette focolarine che andavano insieme verso la casetta di piazza Cappuccini”, la descrive così: “una casetta con le pareti bianche, semplice e povera, con pochissimi mobili e alcune reti per terra con sopra dei materassi avvolti da copertine a fiorellini e il tutto messo con tale ordine, armonia e bellezza, da sembrarmi di stare in un palazzo di Re”. In altra occasione dipinge l’interno di piazza Cappuccini come “spoglio, vuoto, brandine per terra, con delle copertine a fiorellini rossi mi ricordo”, ribadendo d’essersi trovata come nella reggia di un re. “Le finiture e l’arredamento – nota Maurizio Gentilini – erano poveri e minimali; sulle pareti della sala da pranzo campeggiava un ritratto raffigurante il volto straziato di Gesù morente”. “Un motivo – osserva il pubblicista roveretano – per ricordare la necessità di e l’impegno a condividere le tante croci materiali e spirituali di quei tempi di guerra, e di ogni tempo”.
“Era una casa ordinata – aggiunge Maria Elena Holzhauser -, piena di armonia. D’inverno l’acqua era ghiacciata, la grande stufa a legna mandava fumo e sporcava un po’, le assi di legno del pavimento erano belle e lucidate”. “Entrai in quella cucinetta – ricorda dal canto suo Marco Tecilla -. C’erano quattro-cinque focolarine, forse. Nemmeno si chiamavano focolarine. Il Focolare non si chiamava Focolare, ma Casetta. Era la Casetta”. “La luce di quella casa – avrebbe potuto dire Tecilla con Lamartine – brillava fino in fondo all’anima mia, ed era come un lontano splendore di gloria nella penombra della mia giovinezza”.
Poco distante si formerà un altro focolare: Casetta Foco, ove vivranno altre giovani desiderose di far parte di questo nuovo gruppo evangelico: Marilen, Aletta e Natalia. Quest’ultima è Natalia Dallapiccola, soprannominata Anzolòm ed indicata come la prima focolarina avendo incontrato la Lubich nel giugno del ‘43. Anche in Belgio fioriranno le casette “Gen”, di cui Chiara ebbe a dire: “Sono tanto graziose, mi piacciono tanto”. Non è proprio una casetta, invece, la casa di via Spalliera a Trento, donata nel dopoguerra da Duccia Calderari al movimento dei Focolari, cui aderì. Mentre la cittadella focolarina, la microcittà denominata anche Mariapoli (Loppiano la prototipica), può forse essere considerata il corrispettivo urbano e una sorta di prolungamento della Casetta, condividendone anche significativamente il carattere di diminutivo. “Come lo faccio a casa - recita la pubblicità del Brodo Star - ma più in grande”.